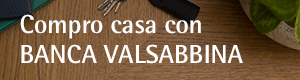Aveva un occhio di vetro che usava in uno strano modo. Quando al campo si giocava la partita, si appostava dietro al muro di cinta alto circa tre metri e lanciando in aria il suo occhio faceva credere ai bambini di poter vedere la partita senza pagare.
Riusciva a dare il meglio di sé quando in paese arrivavano squadre di grossi centri con il seguito di tifosi elegantissimi e raffinati; esaminava attentamente la vittima prescelta e poi partiva all’attacco:
“Scommettiamo che mi mordo un occhio?”.
I forestieri rimanevano dapprima interdetti, ma alla fine i più annuivano ed allora Ricioti si toglieva l’occhio, lo portava alla bocca e offriva agli astanti uno splendido sorriso prima di dargli un delicato morsetto.
I bellimbusti quasi sempre se ne andavano scuotendo la testa, non prima di aver pagato dazio, ma talvolta i più spocchiosi e antipatici, come la gramigna rigogliosi ad ogni latitudine, restavano sbalorditi da un’altra provocazione:
“Scommettiamo che mi mordo un orecchio?”.
“Dai nonnetto!…” si schernivano i saccenti, ma desiderosi di rifarsi accettavano nuovamente la sfida.
Con studiata lentezza Ricioti si toglieva allora la dentiera nuova di zecca ed agitandola ritmicamente come un suonatore di nacchere si mordeva i lobi. Un inchino e la mano tesa per la riscossione del tributo concludeva la sceneggiata.
Sinaba, invece, stava ritto a braccia conserte sul ciglio della strada, dinanzi al portone di casa.
Gli era sufficiente muovere un sopracciglio per far capire come la pensava e un baffo abbassato di tre gradi presagiva severi giudizi per chi, transitando nei suoi paraggi, lo osservava di sghimbescio per carpirne gli umori.
“Parola di Sinaba” si diceva per avvalorare le proprie affermazioni, perché una parola di Sinaba non ammetteva repliche.
Quando venne a mancare, fu come se in paese fosse scomparso improvvisamente il campanile, o il ponte nuovo oppure il municipio.
Anche se pochi si fermavano a parlare con lui, tranne i bambini che lo consideravano quasi un profeta ottenendo invariabilmente risposte positive ad ogni tipo di quesito, ognuno lo considerava parte integrante dell’arredamento urbano.
Palma stazionava stabilmente sul ponte vecchio, sotto il municipio.
Portava calze grosse di lana anche d’estate ed un’immancabile borsa appoggiata all’avambraccio sinistro.
La mano destra, invece, era sempre in aria a gesticolare con il dito puntato contro qualcuno: con quelli “su in comune” che non facevano niente per lei; con gli operai che dovevano obbligatoriamente attraversare il ponte per tornare a casa ed uscendo dalla fabbrica le facevano sberleffi; con i ragazzini che, passandole accanto, le dicevano: “matta, matta!”; con certe donne le quali, credendo di far del bene fornendole dei consigli non richiesti, ne ricevevano in cambio tali profezie, presagi e maledizioni da rendere sconsigliabile l’utilizzo del ponte per settimane intere.
Il negozietto delle “Vecie”, non distante dal ponte vecchio, rappresentava per noi bambini una vera delizia: che felicità nel poter ammirare montagne di giochi, caramelle di ogni tipo e colore, grossi vasi pieni di dolci e di ogni altro ben di Dio.
La domenica, giorno di misera paghetta, le vecchine aprivano la porticina sul retro, cosicchè frotte di ragazzini, prima di recarsi all’oratorio per trascorrere il pomeriggio, si rifornivano delle prime figurine, di farina di castagne e liquirizie, di dolci rari e gustosi.
Chi potrà mai scordare la bontà di una grossa liquirizia intinta in un’arancia o in un limone?
E quando ancora non esistevano doppi vetri ed i televisori eran pochi e soprattutto meno rumorosi, la notte dell’Epifania i gruppi della “Stella” procedevano fino all’alba di strada in strada annunciando l’arrivo dei Re Magi cantando innumerevoli volte “Noi siamo i tre Re venuti dall’oriente”.
Noi tendevamo l’orecchio vicino alle finestre e nel momento in cui si sentivano le prime fioche e lontane note tutti ci precipitavamo fuori per accogliere i cantori con vin brulè e panettoni.
Ancora oggi qualche buon’anima, amante delle tradizioni, si raccoglie in gruppo per cantare la “Stella”, ma TV e doppi vetri, soprattutto quelli applicati ai nostri cuori ed alle nostre menti, ci rendono sordi e ciechi, incapaci di accogliere e di gioire.
Chissà perché non mi decido ad installare i doppi vetri, nonostante gli inverni rigidi del paese di montagna.
Chissà perché i giorni più belli e tranquilli passati in famiglia coincidono con il periodo in cui si ruppe il televisore?
Ci sia concesso ogni tanto di poter rivivere per qualche attimo quelle sensazioni, non come celebrazione, ma come folata di zefiro in un’afosa notte estiva.
E ci conceda un giorno il buon Dio di poter riposare e godere della compagnia dei propri cari e degli amici, gustando in pace un “dolce non far niente”, poiché ora non è ancora tempo di riposare. E se non ci vedremo e non ci sentiremo, perché i sensi saranno svigoriti, ci sia dato almeno di sentirne la “presenza”, quale preludio al paradiso.
Il racconto è tratto dal volume: “Tapascio Bombatus e altre storie” – Ed. Liberedizioni
Il racconto è stato scritto negli anni ‘90